31/01/2011 - L’intervento per il quartier generale dell’azienda Friem, porta la firma di Angelo Lunati e Luca Varesi di Onsitestudio e riorganizza complessivamente l’area adibita alla produzione di convertitori elettrici, ubicata in un comparto industriale lungo la strada statale Cassanese, ad est di Milano. L’idea principale è quella di definire il limite dell’area di intervento con un muro continuo, così da creare una condizione di chiusura dell’isolato. L’edificio costituisce quindi un “inspessimento” di tale muro in corrispondenza dell’angolo, definendo un fuori ed un dentro: un giardino interno e gli spazi pubblici lungo strada. Il programma prevede spazi per la ricerca al piano terra, introversi e rivolti quindi verso il giardino interno, e gli uffici amministrativi al piano primo.
Il volume si piega intorno all’angolo e si allunga con due corpi a sbalzo caratterizzati da nastri vetrati continui; il primo aggetta verso le betulle ed ospita gli spazi direzionali; il secondo si protende verso la strada e ospita gli uffici operativi.
All’estremo ovest, verso la strada statale, il volume si erge a segnalare la sua presenza con un elemento verticale costituito dalle centrali tecniche. La pelle metallica, costituita da lamiere sagomate e forate in acciaio inox opaco, avvolge interamente l’edificio come una tenda continua, conferendo al volume un carattere unitario, in cui parti opache e trasparenti risultano ambiguamente definite. La pelle filtra la luce con differenti gradi di apertura, in relazione all’esposizione solare ed al livello di intimità degli spazi interni.
Rispetto agli spazi indifferentemente aperti, proposti generalmente per gli edifici per il terziario, o alle forme anonime che fungono da sfondo a grandi scritte colorate, tipiche delle aree suburbane di qualsiasi città europea, la percezione generale è quella di un edificio in sostanza omogeneo, il cui carattere speciale è delegato alla complessità del rivestimento. La texture degli elementi metallici è stata sviluppata in più fasi, inizialmente cercando di utilizzare elementi industriali comuni, quali lamiere stirate, forate e piegate, per poi arrivare a una soluzione specificamente disegnata, per assecondare l’idea di un rivestimento la cui varietà si materializza a più livelli, tanto in pianta quanto in prospetto.
Il contrasto tra l’apparente monoliticità dell’intervento e la sua smaterializzazione più nel dettaglio, partecipa allo sforzo d’astrazione su cui si basa tutto il progetto; gli conferisce un’identità precisa e riconoscibile, in cui il carattere urbano di landmark si unisce alla preziosità di tessitura.
Gli uffici operativi sono in corrispondenza dei due aggetti vetrati, uno verso il giardino interno, l’altro verso l’esterno; in corrispondenza di alcuni ambienti il rivestimento si dilata di più per permettere di ritrovare il rapporto con il paesaggio.
In contrasto con l’ortogonalità dell’edificio principale, il giardino occupa gli spazi tra i due corpi e la parte produttiva esistente attraverso forme più organiche, piantumate a Betulla e Convallaria. L’intento, attraverso le essenze scelte, è quello di creare un ulteriore filtro tra gli affacci degli uffici e l’area più operativa, nonché di convogliare i percorsi verso gli ingressi di clienti e addetti in percorsi più definiti.
L’edificio, seppur abbia un coefficiente di forma penalizzante ed un impegnativo rapporto tra parti trasparenti e parti opache, è progettato per avere una classificazione energetica di tipo A CENED. Al momento rimane da implementare il sistema di copertura metallica, già predisposto per essere rivestito da pannelli fotovoltaici in silicio amorfo.
Il progetto persegue gli obiettivi di contenimento energetico attraverso una serie di strategie quali un sistema-involucro ad alte prestazioni sia per le porzioni opache che per quelle trasparenti, sistemi di schermatura esterna dall’irraggiamento solare, tende interne, sistemi impiantistici basati su pompe di calore, recupero delle acque piovane a scopi irrigui.
|
 Rss feed
Rss feed Rss feed
Rss feed




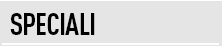

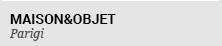

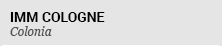
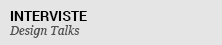

 segnala ad un amico
segnala ad un amico


















