25/11/2013 - Nessun’altra invenzione ha rivoluzionato nell'ultimo secolo il nostro spazio ambientale quanto la luce elettrica. Ha cambiato le nostre città, ha creato delle nuove strutture per vivere e lavorare ed è diventata il motore che ha spinto il progresso dell’industria, della medicina e della comunicazione. Grazie alle nuove tecnologie oggi si sta sviluppando un cambiamento radicale nel mondo della luce artificiale. Ed è proprio a questo sviluppo che il Vitra Design Museum dedica la mostra "Lightopia".
Si tratta della prima mostra che presenta il tema del design della luce – attraverso esempi di arte, design, architettura e tante altre discipline. "Lightopia" contiene circa 300 opere, delle quali tante sono icone della collezione d’illuminazione del VDM mai pubblicamente esposta, come quelle di Wilhelm Wagenfeld, Achille Castiglioni, Gino Sarfatti e Ingo Maurer. Alcuni pezzi espositivi visualizzano l'energia performante della luce, come il famoso "Licht-Raum-Modulator" (modulatore luce-spazio, 1922 – 1930) di László Moholy-Nagy oppure la spettacolare ricostruzione di una discoteca del 1968, interamente realizzata in plexiglas translucido. Al centro dell’esposizione, però, si trovano i lavori di designer ed artisti contemporanei come Olafur Eliasson, Troika, Chris Fraser, Front Design, Daan Roosegaarde, Joris Laarman, realities: united e mischer'traxler che presentano nuove possibilità creative tramite la luce.
Tra le opere interattive sono presenti anche delle istallazioni che si possono percorrere ed attraversare e permettono al visitatore di esplorare la forza elementare della luce. Dal dialogo tra le opere esposte nasce, attraverso la mostra "Lightopia", una panoramica del design della luce – dall'inizio della società industriale, fino alle visioni che caratterizzeranno il nostro futuro. L'esposizione "Lightopia" dimostra, grazie al suo approccio interdisciplinare, come il design della luce abbia formato l'ambiente moderno ed esamina il cambiamento del modello attuale inserendolo in un contesto storico-culturale più grande. A questo proposito, la curatrice Jolanthe Kugler si esprime così: "Lightopia è la prima mostra che, non solo evidenzia il fenomeno luminoso nei suoi aspetti creativi – come l'arte della luce o il design della luce – ma, riunisce tra loro le diverse sfaccettature del design della luce e le inserisce nei discorsi attuali."
1. Living in Lightopia
S’inizia con un inventario del nostro spazio ambientale, intensamente caratterizzato dalla luce. Un’enorme parte della nostra società occidentale è dipendente della risorsa luminosa – sia per la trasmissione dei dati digitali che per l'illuminazione dei posti di lavoro, dei siti produttivi così come per la creazione degli spazi pubblici. Le conseguenze negative di questo progresso sono l’eccessivo sfruttamento delle risorse e l’inquinamento luminoso ma, nello stesso tempo, questa situazione ha anche creato tante opportunità e innovazioni. Soprattutto le nuove tecnologie come LED e OLED rendono possibili le nuove formazioni luminose e fanno sì che la luce diventi più modulare e gestibile come mai fino ad ora. La prima parte della mostra contiene delle opere che dimostrano il significato della luce nella nostra società attuale – dal leggendario Ready-Made "Capri-Batterie" di Joseph Beuys (1985) attraverso la serie "Relumine" (2010) di mischer'traxler fino all'installazione "Temporali" (2013) dell’artista Alberto Garutti che rappresenta la forza della luce naturale attraverso lo strumento della luce artificiale. Vengono affrontati anche numerosi discorsi che trattano il tema odierno della luce, come il divieto ufficiale dell’utilizzo della lampadina elettrica o la differente distribuzione sociale della risorsa luminosa. A questo proposito, alcuni progetti offrono commenti nuovi, innovativi ed in parte anche ironici: come il progetto "Holonzki" di Ingo Maurer (2000), la sua imitazione digitale di una candela in "My New Flame" (2012) oppure il "Rewindable Light" di Arik Levy (1995). Questo prologo della mostra è completato da varie proiezioni, da informazioni storiche e da una generale ed approfondita analisi sull’oggetto di culto che è la lampadina ed i suoi successori nell'epoca digitale.
2. Icone del design della luce
Dopo la panoramica sulla presenza della luce oggi, segue una retrospettiva sul progresso dell’illuminazione. Questa parte dimostra che la formazione della luce è sempre stata uno dei compiti più impegnativi ed affascinanti per i designer, gli artisti e gli architetti. Attraverso circa 50 opere – molte delle quali provenienti dalla collezione del VDM – questo settore della mostra ricalca le pietre miliari del design dell’illuminazione ed analizza i fattori sociali, politici, tecnologici e contestuali in genere che erano responsabili, in egual maniera, delle scelte creative. Così i primi progetti d’illuminazione dello Storicismo della fine del diciannovesimo secolo dovevano nascondere ancora la loro natura industriale e conquistare la simpatia del cliente con forme più familiari e dettagli pseudoartigianali. D’altra parte, i primi designer ed architetti moderni che si avventuravano nella creazione di corpi illuminanti volevano dar vita ad una nuova e reale forma industriale. In seguito, sono nati progetti quali la lampada a sospensione di Gerrit Rietveld del 1922 ed anche la lampada da tavolo di Wilhelm Wagenfeld, del 1923/24, conosciuta per il suo stile Bauhaus. Nei decenni successivi l’illuminazione utilizzata negli atelier fu trasferita in ambito privato grazie ad alcuni progetti tra cui "Anglepoise" (1932) di George Carwardine, mentre i designer del dopoguerra come Gino Sarfatti o Poul Henningsen si occuparono delle possibilità scultoree della luce. Con "Tizio" (1970) di Richard Sapper la tecnologia alogena entrò nei spazi abitativi ed il sistema a basso voltaggio utilizzato nel "Metro" (1982) di Hannes Wettstein fu di così grande effetto per la sua semplicità che presto se ne trovarono copie nei salotti della gente comune.
3. Colore, spazio, movimento
Nella terza parte della mostra lo sguardo del visitatore spazia dalle lampade alla luce stessa. Qui si tratta della capacità della luce di formare spazi, di creare l'ambiente e di raccontare delle storie. La mostra racconta i primi esempi di queste storie, partendo dagli spettacoli di corte con suoni e fuochi d'artificio, che trovavano i propri successori nelle rappresentazioni all’interno di edifici quali il Palais de l'Electricité, in occasione dell'Esposizione Mondiale del 1900 a Parigi. Il significato della luce come strumento monumentale per la messa in scena degli spettacoli pubblici e per la dimostrazione di potere fu rappresentato dai riflettori nell'era nazista ma, lo ritroviamo anche nell'inaugurazione a Bejing, in cui le singole persone diventano dei punti luminosi in una performance gigante. Oltre a questi esempi di manifestazioni pubbliche esiste anche una concezione minore del design della luce che si è sviluppata nella relazione tra l’architettura d’interni e le tendenze artistiche dello stesso periodo. All’interno della mostra, gli esempi di questa concezione sono i già sperimenti filmati degli anni 1920 di Hans Richter oppure il famoso "Licht-Raum-Modulator" (modulatore luce-spazio, 1922 – 1930) di László Moholy-Nagy. Nel dopoguerra la luce diventò un mezzo importante per tante discipline artistiche, come si può osservare nelle opere dell’artista tedesco Heinz Mack, personaggio molto influente e co-fondatore di "Zero", oppure all’interno del padiglione di Philips dell'Esposizione Mondiale del 1958, che unì artisti di varie discipline (Le Corbusier, Iannis Xenakis ed Edgar Varèse) per realizzare un'installazione eccezionale e multimediale con l’utilizzo della luce e del suono. Anche l'adozione dei nuovi materiali nel design è un aspetto fondamentale, perché si vennero a creare nuove possibilità d’utilizzo dei materiali traslucidi. Questo fatto è dimostrato all'interno della mostra con una ricostruzione parziale dello spettacolare locale notturno di Bolzano "Il Grifoncino" del 1968, che rappresenta il mondo psichedelico dei colori dei tardi anni '60. In questo settore della mostra, "Chromosaturation", facente parte della serie d'installazioni di Carlos Cruz-Diez già nel 1955, mantiene una posizione centrale perché analizza in maniera artistica le qualità fisiche della luce e quelle della percezione dei colori.
4. Licht voor morgen
Quali sono le prossime sfide per un uso creativo della luce? Queste innovazioni come potrebbero influenzare il nostro mondo – o come lo stanno facendo? Quali sono i promettenti approcci di designer, artisti ed architetti, con cui si esaminano le nuove possibilità tecniche? Queste domande sono alla base dell’ultima parte di "Lightopia". Da un lato troviamo esposte numerose grandi istallazioni, basate sulle nuove tecnologie dell’illuminazione, come per esempio le lampade "Starbrick" (2009) di Olafur Eliasson, "Bourrasque" (2011) di Paul Cocksedge, oppure "Ropes" (2013) di Christian Haas. Dall'altro lato, invece, ci sono delle opere che sono alla ricerca dell'equilibrio tra la luce naturale ed artificiale, tra la troppa luce e la sufficiente oscurità, tra l'illuminazione generale e l'illuminazione singola e personalizzata. L’illuminazione stradale inizia a reagire alla luce lunare, i lampioni sono attrezzati con indicatori di movimento e le facciate degli strumenti mediatici che sembrano morbide, trasparenti ed illuminate, definiscono lo spazio urbano. Gli architetti come realities:united approfittano della digitalizzazione della luce per creare una una relazione spaziale tra l'interno, l'esterno e l'intorno usando la luce stessa e per dar peso alla forza comunicativa dell’architettura. Oltre a questi grandi progetti, la mostra evidenzia come i diodi luminosi, energeticamente efficienti, riescano ad abbinare l'illuminazione e la produzione energetica, tramite le opere di Joris Laarman, Auger Loizeau, Rogier van der Heide o Marjan van Aubel. I lavori di mischer'traxler o di Markus Kayser dimostrano che anche la luce solare può essere utilizzata in molti modi come strumento per la produzione di luce artificiale. Per questi designer hanno grande importanza le tecnologie che sono diverse dalla lampadina classica, come i diodi luminosi (LED) popolari sin dagli anni '90, oppure i loro successori, i diodi luminosi organici (OLED) che si stanno sviluppando molto velocemente. Questo tipo di strumenti luminosi sono prodotti oggi attraverso processi high-tech e le aziende che ne sono coinvolte utilizzano spesso dei laboratori per le ricerche e dei Think Tanks per occuparsi del futuro della luce artificiale. Questo settore finale di "Lightopia", in cui sono presentate le ricerche futuristiche, è strutturato come un grande laboratorio – all’interno del quale troviamo risultati già esistenti o futuristici, prototipi, esperimenti e visioni che possono cambiare la luce nella nostra vita quotidiana.
Lightopia
28.09.2013 – 16.03.2014
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
|


 Rss feed
Rss feed Rss feed
Rss feed





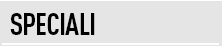

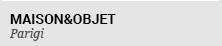

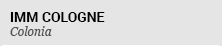
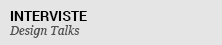
 segnala ad un amico
segnala ad un amico





































































































