 © Lucky Red
© Lucky Red
21/10/2025 - Nel nuovo film di Francesco Sossai, Le città di pianura (Lucky Red), l’architettura diventa racconto e rivelazione. Sossai, regista bellunese classe 1989, noto per il suo sguardo poetico sui paesaggi urbani e periferici, esplora in questo film le tensioni tra città e campagna, memoria e contemporaneità.
Un gruppo di uomini, guidato da Giulio, giovane studente di architettura, si muove lungo le strade del Nord Italia, tra bar di provincia, zone industriali abbandonate e campagne silenziose. Lo seguono Doriano e Carlobianchi, due uomini adulti, compagni di viaggio quasi inconsapevoli, che vivono il percorso più come esperienza esistenziale che come scoperta architettonica. È un viaggio che attraversa le pianure venete, ma anche una condizione più universale: quella di una periferia che non appartiene solo a un luogo, bensì a uno stato d’animo.
Sossai trasforma questi spazi marginali in archetipi di un’Italia diffusa, dove città e campagna si fondono. L’attenzione ai dettagli quotidiani, alle strade di provincia e ai non-luoghi richiama la poetica di Luigi Ghirri, che negli anni ’70 e ’80 ha raccontato con sensibilità le periferie italiane. Le sue immagini, spesso prive di figure umane ma mai prive dell’intervento dell’uomo, restituiscono alla quotidianità una bellezza contemplativa.
L’ultima tappa del film è la Tomba Brion a San Vito d’Altivole, capolavoro di Carlo Scarpa e simbolo assoluto di una sintesi tra materia, memoria e spiritualità. La sequenza finale, ambientata nel memoriale, trasforma l’opera in un vero e proprio dispositivo visivo: le geometrie pure, le aperture circolari, l’acqua e la luce diventano parte del linguaggio filmico. Qui, il viaggio dei protagonisti si chiude in una dimensione sospesa, dove il confine tra realtà e visione si dissolve.
La Tomba Brion appare come un approdo, una soglia che unisce il costruito e il naturale, la finitezza dell’uomo e la continuità dello spazio.
L’opera di Carlo Scarpa
Progettata tra il 1969 e il 1978 per la famiglia Brion, la Tomba Brion è un complesso funerario concepito come un giardino contemplativo. Scarpa intreccia cemento armato, acqua e vegetazione in una sequenza di percorsi e simboli, in cui il visitatore non osserva semplicemente, ma attraversa. I celebri “cerchi intrecciati” – simbolo di amore e unione – racchiudono l’essenza della sua poetica: un’architettura che dialoga con la luce, il tempo e la spiritualità. Scarpa stesso è sepolto in un angolo defilato del complesso, gesto coerente con la sua idea di discrezione e continuità.
Architettura come linguaggio visivo
Nel film, l’architettura diventa uno strumento di narrazione: le periferie, i non-luoghi e gli spazi dimenticati sono trattati come organismi viventi. La camera di Sossai osserva le geometrie minime della realtà quotidiana, restituendo alla città diffusa una dimensione estetica e affettiva. L’incontro con Scarpa non è solo scenografico, ma emotivo: la Tomba Brion non chiude la storia, la eleva, come se l’architettura potesse ancora offrire una forma di redenzione.
|
 Rss feed
Rss feed Rss feed
Rss feed





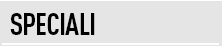

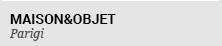

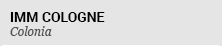
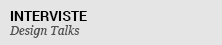

 segnala ad un amico
segnala ad un amico



 Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli Filippo Poli
Filippo Poli






