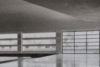|
17/09/2009 – Il Dipartimento di Storia dell’Architettura Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici dell’Univerisità Sapienza di Roma ha organizzato tre giornate di studio dedicate alla figura dell’architetto Luigi Moretti.
L’evento avrà luogo dal 24 al 26 settembre prossimi presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università Sapienza di Roma e vedrà alternarsi in qualità di relatori i più noti studiosi italiani e stranieri dell’opera morettiana.
Intento del convegno è fornire una lettura complessiva dell’opera e della storia professionale di Moretti, dagli esordi romani, nella seconda metà degli anni Venti del Novecento, alla piena maturità con progetti internazionali come la Borsa Valori di Montreal o del Complesso Watergate a Washington.
Giovedì 24 settembre sono previsti gli incontri “Luigi Moretti nella cultura architettonica italiana e internazionale” e “Il linguaggio di Moretti e la ricerca figurative”. La giornata successiva sarà invece dedicata alla figura dell’architetto romano classe 1907 nel primo e nel secondo Novecento.
Infine, nella mattinata del 26 settembre verrà presentato il volume “Luigi Moretti” scritto da Cecilia Rostagni, alla presenza di Franco Purini, Marco Mulazzani e Paolo Fancelli.
La tre giorni di studi si concluderà con la visita guidata ad alcune opere romane di Moretti.
Se vuoi consultare il programma integrale del convegno clicca qui.
Biografia
Luigi Moretti nasce a Roma il 2 gennaio 1907 nel quartiere Esquilino, da Maria Giuseppina e Luigi Rolland, un architetto di origine belga residente a Roma, autore fra l’altro del Palazzo delle poste a Piazza Dante e del Politeama Adriano, il quale non potè dargli il suo nome, ma ebbe probabilmente un ruolo significativo nella prima formazione del figlio.
Luigi Moretti frequenta il Collegio San Giuseppe De Merode, dove porta a termine gli studi primari e secondari con successo. Nel 1925 si iscrive alla Scuola superiore di Architettura di Roma e in ciascun anno del corso consegue il premio Palanti. Si laurea nel 1929 con il massimo dei voti e la lode, con un progetto per un Collegio di alta educazione classica presso Rocca di Papa. Nel 1931 ottiene una borsa di studio triennale istituita dal Governatorato di Roma e dalla Scuola di Architettura, per tre anni poi svolge l'attività di assistente alla cattedra di Vincenzo Fasolo di Storia e stili dell’architettura e alla cattedra di Gustavo Giovannoni di Restauro dei monumenti. Si dedica anche a studi di carattere storico e architettonico e collabora con Corrado Ricci alla sistemazione dei Mercati Traianei.
Nel 1932 partecipa ad una serie di concorsi: il piano regolatore di Faenza, Verona e Perugia e per le case popolari di Napoli; il progetto per il piano di Faenza si aggiudica il secondo posto.
Nel frattempo si dedica anche all’edilizia privata e al restauro.
Nel 1933 partecipa alla V Triennale elaborando il progetto per una casa per un uomo di studio insieme a Giulio Pediconi, Mario Paniconi e Luciano M. Tufaroli. In questo periodo entra in contatto con Renato Ricci, sottosegretario per l’educazione fisica e giovanile e presidente dell’Opera nazionale Balilla. L’incontro determinerà in maniera significativa l’attività del giovane Moretti negli anni successivi. Ricci infatti lo incarica di dirigere l'Ufficio edilizio dell'Opera Nazionale Balilla (in seguito Gioventù italiana del Littorio). Progetta la Casa della Gioventù a Piacenza, quella di Trastevere a Roma, nel 1934 quella di Trecate, nel 1935 la Casa femminile di Piacenza e, nel 1937, la Casa della Gioventù a Urbino e a Tivoli. Sulle principali riviste di architettura cominciano ad apparire numerosi articoli che illustrano le sue opere.
Nel 1934 partecipa al concorso nazionale per il Palazzo del Littorio e per la Mostra della rivoluzione fascista ed è prescelto per la gara di II grado, ottenendo una menzione speciale.
Progetta inoltre il Padiglione alla mostra delle colonie estive al Circo Massimo; l’anno successivo progetta l’ampliamento del Comando generale della GIL e della Sede littoria al Foro italico.
Nel 1936 viene incaricato di redigere il piano regolatore del Foro Mussolini, precedentemente affidato all'architetto Enrico Del Debbio.
Nella stessa area realizza: l'Accademia della scherma, conosciuta anche come Casa delle Armi, la Palestra del Duce e la Cella commemorativa (1940). Gli edifici pubblici che Moretti progetta e realizza segnano una svolta nei caratteri della moderna architettura, in particolare l’Accademia della scherma viene riconosciuta come classico esempio dell’architettura razionalista italiana. Plinio Marconi sulla rivista «Architettura» riflette sul particolare carattere dell’edificio, sugli elementi chiave della trama costruttiva, sulla necessità di leggere l’opera nel contesto della più ampia vicenda costruttiva del Foro che, da luogo inizialmente deputato allo sport, diviene ideologicamente il Foro della terza Roma. Gli viene affidata anche la progettazione del Piazzale dell'Impero e la sistemazione dello Stadio in previsione della visita di Hitler a Roma nel 1938.
Nella intervista concessa a ventinove anni a Luigi Diemoz, pubblicata su «Quadrivio» (dicembre 1936), anticipa alcuni concetti relativi all’architettura che svilupperà poi in seguito.
Nel 1937 lavora a numerosi progetti di edilizia pubblica e privata, si occupa di restauri, allestisce la mostra dell’ONB nella Casa delle Armi. Scrive saggi di letteratura e arte.
A Roma intanto è stato avviato il grande progetto relativo alla Esposizione universale prevista per il 1942: Moretti nel 1938vince, ex aequo con Muratori, Fariello e Quaroni, il concorso per la Piazza Imperiale. Nell'ambito del progetto finale, affidato alla collaborazione dei due gruppi, si occupa in particolare del Gran Teatro, la cui realizzazione viene interrotta a causa dell'entrata in guerra dell'Italia. Molti anni dopo Moretti sarà ancora presente nel nuovo quartiere dell’Eur, dove realizzerà i due edifici gemelli della Esso e della Società generale immobiliare negli anni Sessanta.
Gli anni seguenti vedono la progettazione e realizzazione di numerose opere (centri sportivi, case Gil, arredamenti privati, alcuni piani regolatori), di molti dei quali manca documentazione nel suo archivio, pur essendo citati in alcuni suoi curricula.
Dall’inizio della guerra Moretti sospende la sua attività, le notizie per questo periodo sono alquanto lacunose e frammentarie. In una sua nota biografica autografa inviata a Licia Ponti scrive di essere stato per cinque anni in ospedale a Firenze, Bologna e Brescia. Secondo una testimonianza di Giulio Ricci, dopo essersi trasferito a Milano, avrebbe aderito alla Repubblica sociale italiana.
Nel 1945, fermato dalla polizia a Milano, probabilmente per le sue connivenze col fascismo, e trattenuto in carcere a San Vittore conosce, in quella occasione, il conte Adolfo Fossataro. Insieme fondano la società Cofimprese con l'intento di realizzare opere edilizie. Da questo momento Moretti riprende una fervida attività non solo nel campo dell’architettura ma anche come studioso e critico d’arte.
Progetta e realizza negli anni seguenti opere a Milano con la Cofimprese, tra queste tre case albergo che diverranno un classico di questa nuova tipologia edilizia (la Casa albergo di via Corridoni, quella di via Bassini e quella di via Lazzaretto) e un complesso edilizio per uffici e abitazioni in Corso Italia e a Roma dove tra il 1947 e il 1951realizza per la Cooperativa Astrea un edificio residenziale a Monteverde e la palazzina del Girasole. Dopo queste prime realizzazioni la società si scioglie.
Intanto nel 1950 fonda la rivista «Spazio» e nel 1954 fonda a Roma, con Michel Tapié, la omonima Galleria, due iniziative nelle quali riversa il suo interesse e i suoi studi sull’arte contemporanea con l’intento di concretizzare la fusione di tutte le forme di arte: l'architettura, la pittura, la scultura, il cinema e il teatro.
Sulla rivista, della quale escono solo sette numeri – l’ultimo è del 1953 – Moretti pubblica numerosi saggi in cui sviluppa le sue idee sull’architettura e sull’arte, tra i quali: Eclettismo e unità di linguaggio (1950), Genesi di forme della figura umana (1950), Forme astratte nella scultura barocca,(1950), Colore di Venezia (1950), Trasfigurazioni di strutture murarie (1951) Discontinuità dello Spazio in Caravaggio (1951), Valori della modanatura, (1951), Strutture e sequenze di spazi (1953). La rivista suscita grande interesse nel mondo internazionale per la nuova metodologia di approccio all’arte e all’architettura contemporanee e per la rilettura dell’arte rinascimentale e barocca.
Nello stesso ambito di riflessione teorica si collloca il saggio Struttura come forma del 1952 e il succcessivo Structure comme forme del 1954.
L’attività degli anni seguenti è ricca e diversificata, riceve numerosi incarichi da parte di privati, ma soprattutto da parte di amministrazioni pubbliche ed enti di rilevanza nazionale: nel 1954progetta la villa detta “La Saracena” a Santa Marinella, che sarà compiuta nel 1957, un nuovo complesso residenziale a Genova- Nervi al posto dell’antico albergo Eden e la sistemazione di un nuovo quartiere a Viareggio (1954-58); inizia nello stesso anno il progetto di ampliamento dell'Accademia nazionale di danza di Roma (1955)e il progetto di ampliamento e ristrutturazione dello stadio Olimpico al Foro Italico; progetta a Roma la nuova sede dell’Enpas (1956), a Riyad il palazzo reale (1957).
Redige i progetti per il Nuovo piano di coordinamento dei parchi urbani, suburbani e territoriali di Roma, disegnando nuove strutture viarie che consentano il facile e rapido accesso alle grandi riserve di verde e ai nuovi nuclei residenziali, e per il Parco Archeologico dell’Appia antica (1957-61), a causa dei quali scoppia un'aspra e mai sanata polemica con l'arch. Bruno Zevi. Su «Il Tempo» pubblica una serie di articoli sul piano regolatore di Roma. Rappresenta il Ministero dei lavori pubblici nel comitato di elaborazione del Piano intercomunale di Roma.
Nel 1958 progetta, anche in collaborazione, importanti quartieri residenziali: il CEP di Livorno (con P. Barucci, M. Bellucci, R. Fagnoni) e, a Roma, il Villaggio Olimpico ( con V. Cafiero, L. Guidi, A. Libera, A. Luccichenti, V. Monaco) e il quartiere INCIS di Decima, ai quali lavorerà anche negli anni seguenti, cura la progettazione del Padiglione italiano all’Expo ’58 di Bruxelles.
Riceve, in questi anni, significativi riconoscimenti: nel 1957 il Premio nazionale di Architettura Giovanni Gronchi, istituito dall'Accademia nazionale di San Luca, e in occasione dell’assegnazione del premio presenta una mostra monografica; il Premio Vallombrosa per le attività nel campo della difesa del paesaggio nel 1959, l’anno seguente la Medaglia d’oro per le professioni liberali e l’arte; il progetto del Villaggio Olimpico ottiene il premio IN/ARCH 1961 per la migliore realizzazione nel Lazio.
Nel 1964 ottiene la medaglia d'oro di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte dal Capo dello Stato, riceve il premio conferito dall'Istituto di Architettura di Saint Louis ed è nominato membro onorario dell’American Institut of Architects, è eletto accademico dell’Accademia nazionale di San Luca.
Dal 1957 è consulente esterno della Società generale immobiliare. Per conto della Società nel 1960 inizia a lavorare al progetto per la Stock Exchange Tower di Montreal (con D’Allemagne, Barbacki, Greenspoon, Freelander, Dunne, P.L. Nervi) e per il complesso residenziale Watergate di Washington (con Corning, Elmor, Fischer, Moore); le due opere, che subiscono nel corso della realizzazione numerose modifiche, e nelle quali viene riconosciuta l’introduzione di elementi di gusto latino, contribuiscono ad affermare la fama dell’architetto nel panorama internazionale.
Nel 1957 fonda l'IRMOU (Istituto di ricerca matematica e operativa per l'urbanistica) con l'intento di portare avanti le sue teorie sulla "architettura parametrica", volte all'applicazione di teorie matematiche nella progettazione. Come presidente dell’Istituto, sarà chiamato a far parte di numerose commissioni e interverrà a congressi e dibattiti su temi urbanistici, compie indagini sul traffico, sulla fluttuazione del mercato delle aree, sui fenomeni immigratori nelle grande città . Nel 1960 poi partecipa alla XII Triennale di Milano con una mostra dedicata all'opera dell'IRMOU, nella quale illustra le sue teorie suscitando l’attenzione del mondo internazionale.
Sono ancora da segnalare diversi progetti di urbanizzazione in varie località nei dintorni di Roma, l’allestimento della mostra di architettura e urbanistica a Algeri, poi a Tunisi, l’allestimento della Mostra sulla sanità all’Eur, alcuni progetti di restauro e gli studi per la realizzazione dell’autostrada “dei due mari”, l’allestimento del padiglione del Lazio all’Esposizione Italia ’61 a Torino.
Con Michel Tapié e con Franco Assetto fonda nel 1960 l’International Center of Aesthetic Research (ICAR) luogo di esposizioni, dibattiti e incontri con collegamenti internazionali.
Partecipa nel 1960 alla IX settimana di Arte sacra con un intervento su Spazi-luce nell’architettura religiosa, di fondamentale interesse per comprendere il significato dato da Moretti alla luce “qualità fondamentale dello spazio e quindi della materia che, quale matrice, lo determina. Essa è l’architettura, così come ogni altra cosa al mondo”.
Alla fine degli anni Cinquanta Moretti dirige, nel suo studio, ormai divenuto luogo di incontro a livello internazionale, un nutrito gruppo di architetti ai quali affida, come testimoniano appunti e promemoria conservati nel suo archivio, puntuali incarichi di collaborazione per sopralluoghi, definizione di contatti, correzione di tavole, preparazione di materiali per mostre e pubblicazioni; mentre elenchi di appuntamenti, telefonate e visite dimostrano i rapporti dell’architetto con committenti e personalità diverse.
Tra le opere progettate nel corso degli anni Sessanta sono da segnalare a Roma la palazzina San Maurizio a Monte Mario, i due edifici gemelli all'EUR, sedi della ESSO e della Società generale immobiliare, per i quali vince il Premio regionale IN/ ARCH 1966, la nuova sistemazione delle Terme di Bonifacio VIII a Fiuggi, il progetto per il tronco Termini-Risorgimento per la nuova metropolitana di Roma, il ponte Pietro Nenni, con l’ing. Silvano Zorzi e il parcheggio sottorraneo a Villa Borghese, la villa “La Califfa” a Santa Marinella.
Nel 1968 progetta il santuario sul lago di Tiberiade, a Tagba in Terra Santa; il progetto, che Moretti illustra su «Civiltà delle macchine», viene approvato dalla S. Sede, ma i lavori non iniziano a causa degli eventi bellici scoppiati nella zona tra israeliani e palestinesi.
Estende intanto la propria attività professionale verso altri paesi: progetta la sede dell'Engineer Club e le Beduin Houses per il Kuwait, per i quali vince il primo premio; in Algeria una serie di scuole e di quartieri residenziali, l’Hotel di El Aurassi e il complesso Club des Pins, lavori che saranno portati a termine dai suoi collaboratori di studio, gli architetti Giovanni Quadarella e Lucio Causa e l'ingegnere Pierluigi Borlenghi.
Nel 1971 progetta il centro residenziale sul Potomac ad Alexandria, il centro residenziale a Roquencourt e, a Montreal, sviluppa l'idea di un secondo grattacielo.
Luigi Moretti, nonostante gli importanti impegni nel campo della progettazione, non abbandona gli altri suoi numerosi interessi.
Partecipa al convegno internazionale di studi michelangioleschi (1964) con il saggio Le strutture ideali dell’architettura di Michelangelo e dei barocchi, che verrà pubblicato due anni dopo e produce un film sulla vita di Michelangelo che riceve il premio “Film d'Arte” alla Biennale di Venezia. Nel 1967 svolge una conferenza all’Accademia nazionale di San Luca su Le serie di strutture generalizzate di Borromini.
Nel 1967 riceve il Prix d'Excellence Design Canada e nel 1968 il premio Antonio Feltrinelli dell'Accademia nazionale dei Lincei. Nel 1968 l’editore De Luca pubblica 50 immagini di architetture di Luigi Moretti, con la prefazione di Giuseppe Ungaretti.
Nel 1971 su richiesta del Ministero delle Informazioni e turismo spagnolo, allestisce a Madrid, nell’ambito della Fiera internazionale della costruzione e delle opere pubbliche, una mostra monografica dei suoi lavori. Moretti scegli di illustrare ventuno opere, mediante fotografie e modelli e cura personalmente la selezione dei materiali e il loro allestimento. Svolge poi, sempre a Madrid, la conferenza Habitat turistico e paesaggio.
Nel pieno della sua attività Luigi Moretti muore improvvisamente il 14 luglio 1973.
|
 Rss feed
Rss feed Rss feed
Rss feed



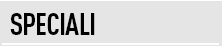

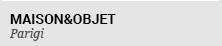

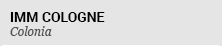
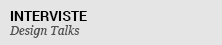

 segnala ad un amico
segnala ad un amico